Le rumànze
In Acri nessuno ha ritenuto opportuno raccogliere le “rumanze”, che le nonne raccontavano ai nipoti, tenendoli inchiodati, per tempo, per ascoltarle e ripeterle ai più piccoli.
Si aveva così l’educazione all’ascolto e l’esercizio di memoria.
Si sbrigliava inoltre la fantasia, facendo aggiunte opportune alle “rumanze” ascoltate.
Vincenzo Dorsa riporta, ne “la tradizione greco-latina”, il pensiero di Herder, cioè che le leggende e i canti popolari, sono gli archivi dei popoli e il tesoro della vita dei loro padri.
Aggiunge la sua considerazione: “le leggende calabresi dette rumanze, sono ramificazioni della poesia cavalleresca; novelle fantastiche con le indispensabili figure dell’orco, del mago, del nano, del demonio, coi draghi custodi di tesori e castella, con le armi e gli anelli fatatI”.
Gennaro Capalbo di Raffaele che, fra l’altro si occupò di cultura popolare, non è d’accordo, ritenendo l’affermazione del Dorsa “poco esatta”. A comprova riporta una leggenda acritana che “rimonta tutt’altro che alla origine della poesia cavalleresca, essendo puramente classica e derivando a dirittura da un noto antichissimo mito”.
La rumanza si rifà alla vicenda classica di re Mida, che fu punito dotandolo di orecchie d’asino.
Nella rumanza acritana il re celava il difetto con opportuni accorgimenti, ma non poteva farlo col barbiere. L’aveva fatto giurare, perciò, di non svelare il suo segreto. Questi, però, sentiva un irrefrenabile bisogno di dire quel segreto. Questo, per lui era diventato una tortura.
Così “gli piovve in testa un’idea – scrive il Capalbo – che gli mise l’animo in pace: andò in un fitto canneto e messosi carponi confidò alla nera terra il suo segreto: il re ha le orecchie d’asino”.
Dice il popolo: ‘Un fari cosa allu munnu ch’ ‘un si sa (Non far cosa al mondo che non si sappia), così un pastorello, non visto, apprese da una delle tante cannucce lì vicino, il segreto. Come? Si era costruito, con un pezzo di quella cannuccia, uno zofolo, che suonandolo diceva: “Te lu rè, te lurè / ricchi ‘e asinu ha lu re”.
Dite voi se il pastorello non rimanesse sbigottito e “andò in città strombazzando ai quattro venti il difetto reale”.
Il re venuto a conoscenza di quanto avveniva convocò il barbiere, unico detentore del segreto, che confessò “il suo fallo” e “sua maestà, molto paziente, gli perdonò e intanto le sue orecchie asinine erano… celebrate per tutto il regno”.
Il Capalbo riporta la versione classica dove il barbiere confida il segreto a una fossa scavata in terra. “La terra, oltre ogni usanza, per divina giustizia, gravida fatta di quella voce produsse quantità di cannucce, le quali cresciute, qualunque volta il vento le percoteva, sonavano propriamente o parea che sonassero in quella lingua queste intese parola: Mida re non ha orecchi d’uomo ma d’asino”.
Il nostro autore conclude: “Ed ora dite: l’arguta leggenda del popolo calabrese, sebbene alquanto mutata e dalla lunga tradizione e dalla viva e immaginosa fantasia di esso, non è proprio il mito degli orecchi di Mida?”.
Riteniamo che la raccolta delle rumanze sarebbe stata cosa utile, per conoscere la sbrigliata fantasia popolare, ma per cercare di individuare da quali fonti derivassero quei racconti così avvincenti.
Ora moltissimo s’è perso. Si dice, da qualcuno, che tale perdita è dovuta alla civiltà che avanza.
Questa è Civiltà?
Le argomentazioni conseguenti potrebbero essere tante e diverse, ma ognuno faccia per suo conto.
Giuseppe Abbruzzo




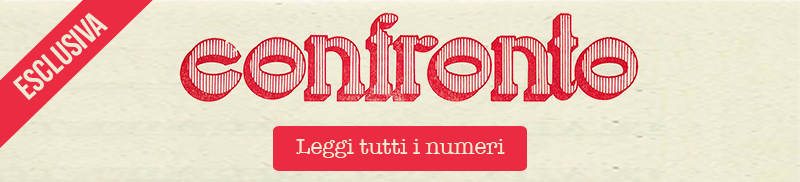








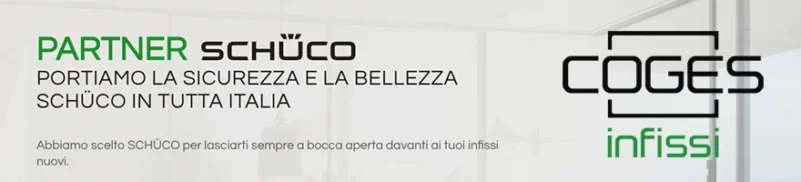
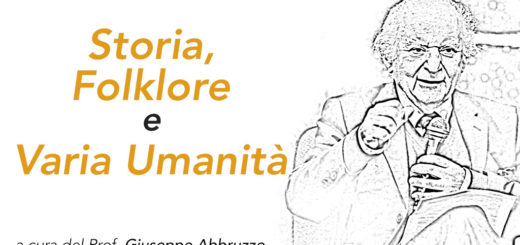
/resolutions/res-l500x500/ap8-calabria-rc-(2).png)





